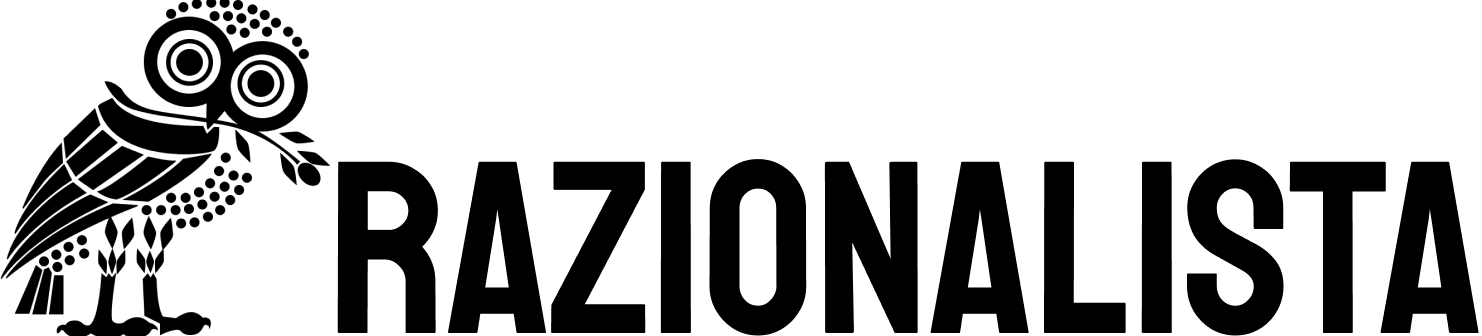Jurassic Park

Capitolo I: L’ASCENSORE SOCIALE SALIVA E IL PALAZZO CROLLAVA
Ovvero di come imparare a contare
L’infanzia ha il colore delle pareti della sala da pranzo, illuminate dal sole di una mattina di primavera ancora timida, ha il suono della voce della tua famiglia e la stabilità del mondo è affidata alle stringhe delle scarpe, che non sono nemmeno affar tuo, “amorosa quiete” e incomprensibile sollecitudine.
La preadolescenza ha il colore della tua stanza, illuminata da una lampada alogena che tarda a sgocciolare la sua luce gialla, ha il suono di qualche canzone di merda che ascolti solo per stare nel consesso civile e la stabilità del mondo è un punto interrogativo di una domanda che ancora non ti poni. Le scarpe, però, sono ben allacciate.
L’adolescenza ha il colore delle pavimentazioni improbabili della periferia della periferia, sporcate dal vento impolverato da qualche cantiere a sua volta impigrito da debiti e sigilli, illuminato verso sera da un faretto che è come mascara messo alla buona per coprire le rughe di un prossimo fallimento, ha il suono di una bottiglia di vetro che rotola sui mattoncini pronunciando fantasiosi nomi vietnamiti, o coreani. I lacci delle scarpe oramai sono di libera interpretazione, la consuetudine con la decadenza e il fallimento iniziano a sbilanciare il baricentro del mondo.
Allora scegli: lo squallore o la prospettiva. Se hai fortuna studi, vai bene a scuola, ammazzi il maiale della pochezza con la lama della preparazione. Sei la punta di diamante della famiglia, quello “studiato”, benevolmente sobillato con la promessa di una carriera, di una professione, accompagnato -se non strattonato- con furibondo amore verso le porte scorrevoli del meraviglioso ascensore sociale e da questo verso un sistema verticale, lineare, trasversale ai piani dell’esistenza e della morale, con capienza limitata, qualche presa d’aria ai lati e un grosso specchio con cui guardarti le spalle.
Cominci dal piano interrato, il garage, dove si buca il figlio di quello del quinto piano: dici di no alle spade e il gioco è fatto, poco male. Sali al piano seminterrato dove il figlio grande di quello del primo piano buonanima gioca a fare il satanista vicino al quadro dei contatori elettrici e disegna volti diabolici sui muri, dove i corridoi lunghi e bui intrisi di piscio (quello sì, infernale per davvero) alternano le porte di qualche magazzino a quelle di qualche altro magazzino magistralmente convertito in abitazione abusiva. Basta dire di no alle stronzate esoteriche, tenersi il piscio per posti più ventilati e non essere scientemente derelitto: con un po’ di sforzo e di fortuna anche qui il gioco è fatto.
Piano terra. Dentro o fuori. Puoi lasciare il gioco e uscire alla luce del sole o all’ombra del cantiere, sulla terra battuta del campetto, o al bar, metterti su un motorino, giocare con qualche cane spelacchiato o romperti i coglioni davanti ad una rosticceria, la cui insegna gialla fa un po’ di luce verso sera rispondendo timidamente al faretto del cantiere come a dire: “okay le speculazioni edilizie, ma il panzerotto resiste. Sia fritto che al forno; meglio fritto. E una porzione di patatine con tanto ketchup ché a casa lo vietano perché ha un nome straniero e per fidarci serve un po’ di tempo e soprattutto meno aceto, ma comunque in fin dei conti panzerotto c’è, panzerotto c’è, e rimane nella luce”.
Se invece preferisci il buio, c’è sempre il parchetto dei drogati, irrinunciabile elemento di arredo urbano di ogni periferia che si faccia male da sola.
Continui a giocare, non sai bene perché, ma sei al primo piano: guardie e ladri. Polstrada e malavita organizzata si alternano sul pianerottolo in una quadriglia di notti lunghe e insonni, pezzi di cristiani nei canali di scolo, custodie cautelari e condanne definitive, mazzi di bamba per restare svegli, pistole di ordinanza e non. Più defilati i professori dell’ I.T.C. , quasi stonanti nel loro aspetto ordinario, vivacizzati dal mefistofelico figlio che poi, tutto sommato, non ha nemmeno cattivi gusti musicali. Gioco facile: sei nipote di un poliziotto quindi non sarai mai né poliziotto né delinquente. Devi essere “di più”, sai che puoi esserlo.
Secondo piano: il preside, terzo piano: il bancario e la farmacista, quello che lavora al ministero.
Ma tua nonna paterna disse di te, appena nato, che saresti stato scienziato. “L’anima mia si volge a te”, sei arrivato al quarto piano, tra le pareti di casa tua. E sei quasi maggiorenne.
L’incompiuta di tuo padre, le scelte di tua madre, quel matrimonio pericolante, lo zaino dove capita, le scarpe sfilate tallone contro tallone e sparate a fanculo con buona pace dei lacci, le paranoie, i Clash, pavimenti scheggiati da piatti caduti e telefoni divelti e schiantati a terra, il crocefisso e la bibbia, mucchi di agende vuote, sempre dell’anno sbagliato, infiniti pomeriggi invernali di solitudini più o meno meritate, le frane emotive, le slavine ormonali, natali inesistenti, epifanie irricevibili, pasque di insurrezione e pasquette di resurrezione.
Ti ricuci alla cazzo, disegni una tua personale epica, condividi il miraggio con i tuoi compagni di scuola, dove i professori ci caricano a pallettoni per il mondo del lavoro, lo spietato, pericoloso, devastato, postideologico, postqualcosaltrico, ondanomalo, brutalissimo, brunettosico, berlusconico, scarnissimo, competitivissimo, americanissimo, mezzofondistico, parossistico, perigliosissimo, hungergamissimo, trinceristico, combattivissimo, tekkenissimo, georgedoubleubushissimo, digimonissimo, austerlitzsimo mondo del lavoro. Indossi il tuo vestito da “sud e isole” e te ne vai, ci provi, sembra funzionare, l’ascensore sale, ci credi ancora, “leggo la targhetta, quanti chili porta e se c’è pericolo per l’ascensore”.
Università, esami, conati, ti rompi il culo, ti mangi il fegato, ti rovini lo stomaco, ti rompi il filetto, ti fischiano le orecchie, hai la bava alla bocca, tiri la coda a sto cazzo di futuro luminoso che scappa come un mustelide lappone che ha scordato le ciaspole, sei la vedova della tua adolescenza e l’amante della tua età adulta, ci sei quasi, senti con la punta delle dita ciò che hai inseguito da sempre.
Laureato.
E mentre ti proclamano Dottore in questo e quello, in scienze di tale cosa, in lettere con o senza scarpe, riesci a sentire il campanello dell’ascensore che ti dice che più di tanto non si sale, sei arrivato.
E mai, mai più, come in quel momento, quel campanello suonerà come la più grande pernacchia della tua esistenza.
E sei nel lotto dei più fortunati. E Bravi. E fortunati.
Di quello che avevi prefigurato, niente corrisponde a verità, tutto è diverso. Il tempo della tua ascesa è stato anche il tempo di politiche sociali e del lavoro, sia nel settore privato ma soprattutto nel settore pubblico, che hanno scientificamente scarnificato il tuo programma, il tuo .exe.: deterioramento dell’immagine pubblica del lavoratore, riduzione della dialettica a mero confronto eristico, quasi mai virtuoso, mai costruttivo, sostanziale svendita del paese alla fiera dei tycoon e degli avventurieri, lo Stato declassato ad amico scemo da fregare, così come chiunque lavori per esso, dalla guardia all’insegnante, passando per il medico, l’amministrativo, il funzionario: parole impolverate che sanno di naftalina come la giacca di Achille. Non vengano a parlarmi di sogni, non siamo Della Valle, non siamo Agnelli, non siamo Luca Cordero di Montezemolo!! (So che l’hai letta con la voce di Marco della Noce). Io a 8 anni volevo un enorme Buzz Lightyear cromato per Natale e mi hanno fatto “nein”, quindi il mio sogno sta ancora sul catalogo della Giochi Preziosi o sul retro di qualche edicola, anni dopo. Ma avevo il Game Boy, quindi muto.
Noi si voleva un lavoro, non i sogni e le stronzate da rivista patinata. La concentrazione era tutta su questo stramaledetto ascensore sociale. Lo stramaledetto ascensore sociale che saliva.
L’ascensore sociale saliva, il palazzo crollava.
Capitolo II
IL MONDO PERDUTO
Ovvero di Isla Nublar e dei suoi magnifici esemplari
Hai vinto!
Ora sei un professionista, ti iscriverai ad un albo, pagherai le tasse di questo o quell’ordine e rischierai di ritrovarti come un dinosauro di “Jurassic Park II: il mondo perduto” cioè nudo, a vagare allo stato brado per tutta Isla Nublar, perché l’uragano ha abbattuto le recinzioni elettrificate.
Orchestra d’archi e fiati con qualche tocco di campane tubulari, prospettiva a volo d’uccello: eccole lì, affollatissime mandrie di erbivori si spostano acefale lungo immense distese verde speranza, saccheggiando pascoli di bandi ministeriali, mentre altri branchi di goffi quadrupedi guadano a fatica acquitrini di graduatorie e scambio/cedo, azzoppati da raptor famelici che come fantasmi appaiono nella radura delle assunzioni a tempo e dei contratti capestro, a loro volta costretti a rifugiarsi vigliacchi dalle incursioni aeree dei tremendi pippofranchici co.co.co., svincolatisi dalle ormai vetuste voliere delle prestazioni occasionali, aventi solcato rapidissimi i crinali delle somministrazioni di lavoro e delle agenzie interinali, per poi impennare sino a scrutare, in lontananza, ordinati gruppi di triceratopi brucare il proprio tempo sulle dolci colline del lavoro in agricoltura, sotto lo sguardo severo di qualche caporale di Latina (Indiana), quindi le bianchissime scogliere del lavoro intermittente, i luminosissimi lidi dei lavori stagionali, bagnati dall’infinito mare dell’apprendistato, dove piccoli Ittiosauri ammucchiati in banchi chilometrici fanno capolino per cinque minuti d’aria e una sigaretta rossa lasciata a metà, prima di riscomparire fulminei nella loro apnea tra le onde verde e blu Hunky Dory, che nemmeno una pisciata gli cambia il colore. Nemmeno una pisciata.
Il sole adesso si abbassa, quasi a solleticare il pelo dell’acqua che circonda Isla Nublar. Ecco che ti prende il terrore: tu non vuoi essere né un goffo erbivoro quadrupede, né un velociraptor caporale di giornata, tantomeno un dinosauro alato o un rettile degli abissi, e decidi di volare alto su tutto ciò perché hai conquistato un elicottero, le tue orecchie tremano come se avessi un martello pneumatico tra i denti, il rumore è assordante e il vento sul volto ti tappa la bocca e il respiro, facendoti ingoiare a forza l’ultimo boccone di erbaccia di pascolo, quella dell’ennesimo concorso, di quella graduatoria che hai pregato tutti gli dei e hai dato l’8 per mille all’associazione degli induisti italiani, che hai imparato il Bhagavadgītā (CTRL+C! CTRL+V!) che nemmeno Oppenheimer, che oggi con la Kippah e domani chi lo sa, che “in hoc signo vinces”, che per Diana, per Giove e per la Maiella, finalmente ci sei!
Sei sull’elicottero che ti porterà al – rullo di tamburi- tempo indeterminato!
Sì! Hai capito bene, asciugati gli occhi! Sei su di una libellula di ferro abitata da te, da un pilota occhialuto e da un vecchietto vestito di bianco troppo intento a guardare fuori per rivolgerti anche un solo sguardo. Un elicottero che ti scorterà al sicuro , sulla terraferma, lontano dai drammi di Isla Nublar, stabile e satollo sull’atollo delle timbratrici, quelle del famoso cartellino che a un certo punto della storia ha cominciato a chiamarsi badge, quelle timbratrici che da nord a sud hanno come sfondo innumerevoli pizzini più o meno intrisi di disperazione, di “cerco”, “scambio”, “cedo”, “vi prego aiutatemi”, spalmati su una matrice informe di numeri di telefono, indirizzi con nomi di vie di martiri di questo e quel posto africano o romano, improponibili luoghi geografici, ora a portata ora lontanissimi, ora in Times New Roman, ora in Arial, Verdana, Comic Sans!
“Per avere buone risposte bisogna porre buone domande” (e con il giusto carattere, mi sento di aggiungere).
Capitolo III
LA GROSSA “H”
Ovvero di quella che in prima elementare ci spacciarono come “mutina”
Una grossa “H” circa cento metri più sotto ti fa capire che sei arrivato, il volo si fa stazionario e la discesa è curiosamente dolce. Le pale girano ancora, ma finalmente, il vecchio di bianco vestito e barbuto, ti rivolge la parola, mentre con una mano accarezza il pomello d’ambra del suo bastone d’avorio e con l’altra si aggiusta gli occhialini ovali dalla montatura d’un sottile metallo smerigliato. La sua voce resta bassa, ma penetra rumore e vento, giungendo nitida.
“Buongiorno, ora che il giorno sta finendo.
Sono quello che deciderà per te, finché tu non diventerai me.
Durerò per sempre, più del tuo primo matrimonio e forse anche più a lungo del tuo secondo matrimonio.
Spero di no, ma potrei sopravviverti.
Spero di no, ma potrei sopravvivere a tuo figlio, a tua figlia.
Ti darò dei giorni di respiro, quando ne avrò voglia.
La mia età è assoluta.
Hai subito la condanna del tempo da quando hai cominciato ad urlare, a testa in giù, sporco delle deiezioni di tua madre. Io ero lì, in un angolo, sapendo che ci saremmo rivisti.
Sopravviverò anche a tua madre, se ce l’hai con te da qualche parte.
Sono la porta di casa tua che si chiude ogni mattina dietro le tue spalle, sono lì ad aspettarti sulle scale del tuo palazzo quando sei in casa, per il giorno dopo.
Sono il profumo silenzioso della notte che ti vede guidare assonnato con lo stomaco a pezzi.
Sono la solitudine che non vuoi meritare, il tedio delle domeniche pomeriggio quando la tua squadra vince, perde o pareggia, perché tanto la sera si avvicina lo stesso.
Sono la tua ragione personale, la tua questione privata.
Sono l’orologio che rompe le lancette del tuo tempo.
Sono quel cielo grigio che non vuole piovere.
Sono quell’asfalto infuocato, che non vuole smettere.
Sono quel posacenere annerito, ché non puoi smettere.
Sono la tua voce al telefono, strozzata e insieme baritonale, quel boccone che hai mandato giù di fretta.
Sono quello sguardo che meglio di no.
Sono quegli occhi che meglio di no.
Sono quella tosse che non passa mai del tutto.
Sono quello che “come al solito”.
Sono quello che “una volta…”
Sono quello che otto quattordici, otto sedici, otto venti, sette ventuno, sei quattordici, ventidue otto.
Sono quello che “voi giovani”
Sono quello che “è tutto uno schifo”
Sono quello che le ferie a settembre
Sono quello che “pensi di fare un figlio?”
Sono quello che “non vorrai mica fare un figlio?”
Sono quello che “cosa aspetti a fare un figlio?”
Sono quello che ti mette lo sgambetto.
Sono quello che vorrai farla finita con me, ma non saprai cosa fare dopo.
Sono quello che devi mangiarlo anche se ti fa schifo.
Sono quello che “in Africa muoiono di fame”
Sono quello che climatizzatori in casa, piattaforme streaming, console di gaming e corso di spinning.
Sono quello che a pranzo il panino e la sera lattughino.
Sono quello che di sabato, in mia assenza, il meglio che fai è la pizza nel solito posto, la birra nel solito posto, la macchina nel solito posto, l’amore nel solito posto.
Sono quello che ogni mattina nello specchio ti conta le rughe e i capelli rimasti, fino a quando non vinceranno le rughe per distacco.
Sono quello che l’umido il martedì sera sennò il mercoledì mattina fai tardi.
Sono quello che se fai un figlio ti accarezza con l’ossigeno, lo stesso ossigeno con cui ti accarezza se perdi qualcuno, sono quello che è meglio se per un po’ non ci sentiamo.
Sono quello che hai un bel SUV, forse pure troppo.
Sono quello che non perdi tempo a cucinare.
Sono quel cassetto del comodino che ci tieni dentro le cose più importanti ma non lo apri mai.
Sono quello che ti vedo quando porti la trapunta sin sopra le orecchie, per nasconderti, quando fuori piove e fa freddo.
Sono quello che la nebbia prima o poi va via e invece no.
Sono quello che le scarpe devono essere comode.
Sono quello che il ventisette busta paga. Mittente: Isla Nublar; destinatario: tu
Sono quello che il ventisei detrazione dalla busta paga. Destinatario: Isla Nublar; mittente: tu.
Sono quello che ora sei un privilegiato.
Sono quello che sotto sotto non ci credi.
Sono quello che se hai una passione, te la violenta.
Sono quello che se hai una gioia, te la inzuppa.
Sono quello che ti fa da nemico, quando non lo sei tu per te stesso.
Sono quello che non si torna indietro mai più.
Sono questo, e molto di più di questo, ma so che hai paura di farmelo dire.
Ti ho detto cosa sono e ora ti chiedo: dammi un nome.
Chi sono io?
Il tuo principio o la tua fine?
Il senso delle cose o l’entropia ultima del tuo universo?
Chi sono io, dunque?
Sono Il Lavoro o il senso di colpa?
Lo vedi il pilota? Lui la risposta l’ha trovata, forse.
Tu?”
E tu?
Tu resti muto?