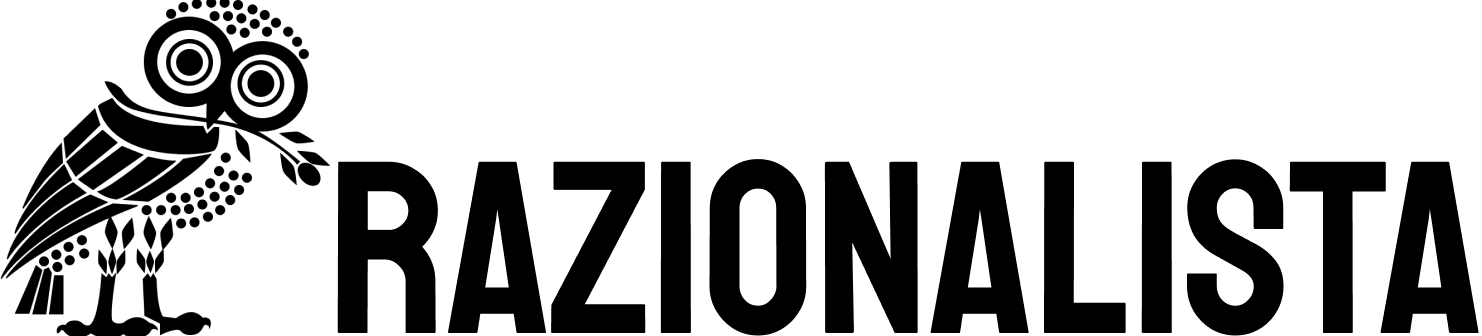Il provino

Ero ad un provino per entrare in una piccola compagnia teatrale. I provini si tenevano in un piccolo teatro, ci stavano strette al massimo 80 persone su per giù.
La giuria, la commissione, era composta da 4 persone: da destra, un uomo abbastanza smilzo, con il tipico dolcevita nero, occhiali a montatura spessa e con i capelli color carne, mentre l’accento tradiva inequivocabili vocali lombarde frustrate dall’essere ad ovest del Ticino, tipiche del più modesto novarese. Una specie di Stanley Tucci di Borgomanero che vorrebbe tanto tornare a casa per guardare cosa ha combinato in soggiorno il suo interior designer preferito.
Al suo fianco, una donna con i capelli rossi, sparati un po’ qua e un po’ là come l’ovatta che fissi inerme mentre stanno per pungerti una chiappa. I suoi lineamenti non mi erano molto chiari dietro i suoi occhiali a maschera, ma distinguevo bene l’oro che portava addosso: praticamente un cesso dei Casamonica.
Il più idolo di tutti era senza dubbio il terzo giudicante: un uomo di mezza età, d’aspetto fresco e giovanile, fiero capello lungo brizzolato, bell’aspetto, mascella sagomata il giusto e voce sagomata pure meglio da una lunga storia di tabagismo raccontata male dalla nuvoletta di vapore della sua nuova sigaretta elettronica, che dava al piccolo ambiente la fragranza di un vecchio bar con il menu appeso alle pareti specchiate, con le letterine bianche in plastica, applicate su sintetica moquette nera o verde. Uno che, se ti volesse vendere l’auto, non ti fideresti.
Infine, con capo chino ed occhi chiusi, male illuminato, un minuscolo figuro dalle orecchie appuntite almeno quanto il naso, che sembrava appunto dormire o meditare, tipo il maestro Yoda. Di lui mi colpì anche il fatto che la sua pelle avesse un aspetto giallastro. Era distante, distaccato dalla luce e da tutto il resto, praticamente indifferente. Una specie di Yoda giallo che se ne sbatteva forte forte il pisellino laser.
Prima di me, diversi altri ragazzi avevano sostenuto il provino: qualcuno bravo ma un po’ cicciottello, qualcun altro meno bravo e decisamente cicciottello, ma frocio il giusto, un paio di brave attrici e la solita squinzia, per cui ovviamente facevo il tifo. Subito prima del mio turno, toccava ad una ragazza: non l’avevo mai vista prima, di solito ci si conosce più o meno tutti ai provini. Bella era bella, il portamento elegante le dava chiara sicurezza e il passo, per quanto svelto, non violentava le assi del palco che anzi restavano in rispettoso silenzio sotto i tacchi della musa. Io, sognante, ammiravo.
Per l’emozione non si presentò alla commissione, che la introdusse amichevolmente alla platea: si chiamava Clio.
“Anfatti” mormorai tra me e me in una lingua non mia.
“Cosa ci fa sentire?” le chiese il cesso dei Casamonica
E in quel preciso istante ebbe luogo un tracollo generale, un sacco di Roma, una gang bang di Lanzichenecchi, una Caporetto dell’eros, una Waterloo di testosterone, uno scippo di emozioni.
“Porto in scena il monologo di Puck della seconda scena, atto III del Sogno di Shakespeare”.
La voce della ragazza era profonda, rauca, baritonale al punto che quasi potevo avvertire il peso dei suoi testicoli immaginari.
Il monologo era finito. Mi sembrò di aver ascoltato una lunga intro di un pezzo di Barry White, di quelli in cui lui comincia a parlare con un sottofondo incalzante, con quella strana sensazione di averlo già nudo sul letto di là che ti aspetta con una bottiglia di champagne in mano e il preservativo elegantemente poggiato sulla radiosveglia.
Sentii chiamare il mio nome. Lasciai la camera da letto immaginaria scusandomi con Barry, che elegantemente accolse.
Entrai sul palco senza particolari preoccupazioni: “del resto” - mi dissi- “che me ne frega, voglio dire, so’ urologo, anche se mi potano, casco in piedi”. Preoccupazioni che del resto mi avevano già portato a non preparare effettivamente nulla e a puntare tutto sulla simpatia e sulle gambe lunghe come la squinzia di inizio giornata per cui avevo fatto così tanto il tifo da dover nascondere l’erezione con una seduta strategica in accavallamento strozzagonadi e tritacarni.
“Cosa ci porta?” “Cosa ci fa sentire?”
Stanley Tucci novarese e Capello Lungo Brizzolato si erano sovrapposti nella domanda, generando sottilissimo e brevissimo imbarazzo nel micromondo della commissione; “un punto per me” pensai, mentre Yoda Giallo sembrava ancora in meditazione profonda, al punto da russare forte (i suoi atti respiratori erano tuttavia gravi e solenni, come si confa ad un maestro Jedi).
Dopo una breve presentazione, incominciai: del tutto impreparato.
“Gentili membri della commissione, vi giuro che avevo preparato la stessa identica scena della ragazza di prima, solo che invece io pensavo di farla con voce femminile” pensai che prendere per il culo la concorrente prima di me – giustamente tra l’altro- poteva essere un’ottima mossa per rompere il ghiaccio.
Osservai le reazioni dei fantastici quattro:
Stanley Tucci accennò un sorriso con sguardo serio, tipo un gay che si offende.
Il cesso dei Casamonica faceva finta di guardare il telefonino digitando a casaccio con le sue dita tozze.
L’unico a darmi soddisfazione era Capello Lungo Brizzolato caviglia abbronzata in vista e mocassino con suola in gomma a mescola morbida per tutti i tipi di yatch. Lui rise, sollevando la sigaretta elettronica come se volesse brindare con quest’ultima, o come se volesse usarla come un fumogeno allo stadio.
Yoda giallo sollevò di scatto il capo. Dischiuse gli occhi e mi fissò. Il suo sguardo era severo, ma limpido e blu cobalto. Sentii che lo sguardo dell’arte si era poggiato su di me, che ero riuscito a catturare l’attenzione del più ruvido dei miei aguzzini pro tempore grazie ad un colpo di teatro, una giocata geniale, una prova solida di improvvisazione.
“Senta, la smetta con queste schwachsinnen, ci faccia ascoltare quello che ha preparato e torni al suo posto, io non ho tempo da perdere, guardi quanto so’ giallo!”
Il sogno si fece colica.
Per qualche secondo ero tentato di fare domande, ma la rabbia di Yoda Giallo sembrava vivere di vita propria e fare capolino come un colpo di sonno. Superficialmente, attribuii il suo nervosismo e la sua voglia di menare al suo stato di salute quasi al punto da comprenderla. Il suo tempo era prezioso. Il suo tempo era finito. L’orologio posto sulla testa di ognuno di noi? Lui sapeva che ora facesse. Ma poi, dopo alcuni secondi di silenzio capii: la sua rabbia non nasceva nella sua malattia, nel suo colore, ma dal fatto che aveva appena smesso di sognare. Quasi per ripicca, come a ripristinare il sogno che meritava o – più vigliaccamente- per paura di ritrovarmi prima del previsto nelle sue condizioni, incominciai a sognare più forte, a parlare come se fossi nel mio sogno, incominciai a sognare ad alta voce, e la voce si fece parola mentre i sogni diventarono cristallini nella mia mente: “essere o benessere? Questa, la domanda”.
Da lì in poi il ricordo delle mie parole è confuso, la lingua mise il pilota automatico, via via le maglie del filtro tra la mente e le labbra divenivano più larghe e permissive, gli sfinteri chiusi in uno spasmo coitale a srotolare le pergamene di mille illusioni, in una nuvola di ghirigori jazz, di vapori fusion, ascensori sociali, periferie malfatte, di cucine unte, di corpi disfatti, di eroina e poi dinosauri, distese infinite e canederli sexy, Venditti a Parigi, Romario e Bebeto, di Sacco e Vanzetti, dell’Ara Macao e poi Alba Parietti tornando da Shakespeare, vita e sonetti.
“Per carità…Per carità…” Yoda cominciò a parlarsi addosso, con le mani a pressarsi il volto da guancia a guancia. E poi ancora, incalzando: “basta santoiddio, basta!” Fino a tuonare: “basta, Giove Pluvio! Ci liberi da questa tortura, per cortesia! La faccia finita!”.
Le mani avevano abbandonato la faccia gialla e gli occhi sembravano pronti ad essere sputati fuori insieme al veleno acido di bile, la lingua verdognola si scrostava in rigagnoli rosso sangue che umettavano labbra secche di vetro. Io, feci silenzio, a schiena dritta, pronunciando il mento, ma lui era inarrestabile e seguitò a vomitarmi:
“Ma secondo lei, ma dopo cinquant’anni di teatro, provini, preparazione, letture, rotture di Hoden, sigarette a pacchi, grappa a litri e fregature a chili, mi faccio prendere per il sederino dal primo signor nessuno che viene qui a fare la maestrina? Secondo lei ci stupiamo o restiamo esterrefatti dal primo idiota senza arte né parte che punta il dito indice e sbandiera il dito medio? Che con gli occhi foderati di bresaola Conad, tipici di chi ha avuto già tutto, colpisce la pignatta di chi vuole tenerselo, quel “tutto”? Ma lei crede davvero di aver capito Brecht? BRECHT!
Lei! Un pincopallino venuto dalla cacchina d’Italia, che viene ad ergersi tronfio e pieno di sé, camuffato da antieroe di una generazione di maldestri privilegiati con la pretesa di raccontarci le nostre colpe e metterci davanti ai nostri errori, fiero nel suo pigiama da Super Pippo, sgranando una per una le nostre responsabilità davanti a questo scempio di nazione? Proprio lei, che da quando si sveglia stordito e imbecille, con la fortuna in tasca, un orologio al polso e il latte in frigo?
Pezzo di cretino, crede davvero che non sappiamo già di esserci mangiati tutto?
Non crede che io sappia già, e benissimo, che l’ultimo mio ricovero, quello del mese scorso -da solo!- valga quanto un anno di pensione di qualche schwachkopf della sua generazione? Lo so benissimo, glielo ripeto.
Ma non me ne frega niente. Ma proprio niente, niente! Niente! Niente! Niente! Niente! Niente! Niente! Niente! Niente…”
La salmodia di “niente” durò qualche altro secondo, mentre –incuriositi- gli altri candidati del provino, più o meno tutta gente dalla mia età in giù, cominciarono a riempire i lati della platea, qualcuno cominciò ad accomodarsi perfino. Non lo giurerei in un aula di tribunale ma sono quasi sicuro di aver addirittura intravisto il bagliore di qualche busta di patatine.
Yoda riprese fiato, col naso, a bocca chiusa, stirando il collo all’in su e disse sgonfiandosi: “Noi, noialtri, questa fase della disillusione l’abbiamo vissuta e l’abbiamo metabolizzata e non (acuto, afono, ndr)…E non (calmo, umido, ndr) facendo cover delle cover su quattro assi fradici di legno fissati alla meglio, ma contando i morti di piombo e i feriti sull’asfalto, sperimentando e inventando, rubando e stuprando, fingendoci moderni e progressisti affinché il favore delle tenebre rendesse più agile il nostro vero intento: prenderci tutto, spolparlo e rosicchiarlo all’osso, violentando, rinnegando, tradendo e depredando ogni goccia di ideale e se non riempirci le tasche di soldi, almeno creare gente più povera di noi: derelitti, tossici, malati cronici, morti di lavoro. Perché a noi, la frustrazione fa schifo, sì, ma la povertà di più.
Ora, caro il mio vittimista del ciufolino, che si sente tradito da mamma Rai e da papà Ministero, lascia questo palco, esci dal teatro e dì questa cosa da parte mia agli animali da cortile come te: inventatevi qualcosa, se ci riuscite, rucke, in caso contrario potete serenamente continuare a pulirmi il c…!”
A quella “C” dura (durissima, invero), checché possa pensare chi legge, non fece seguito una “U”.
A dirla tutta, non fece seguito proprio nulla.
Un gemito acuto e flebile, un rigurgito e poi un rantolo.
Quindi un tonfo.
Morto, lui.
Quindi un inchino, io.
Applausi, e tragedia fu.