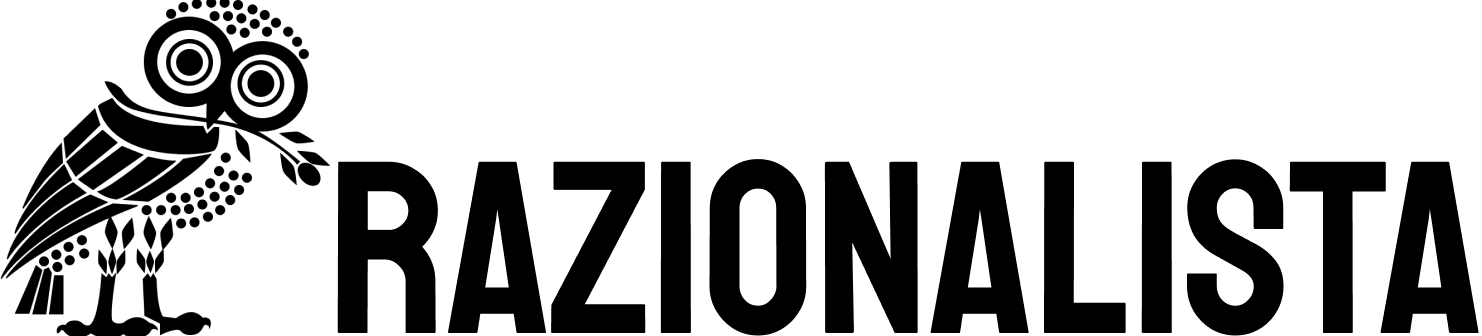Il capobranco

Un sapore dolciastro in bocca, come di sangue e ruggine. Erano giorni che non mangiavo qualcosa di fresco, ma in cuor mio sapevo che avrei dovuto ben presto fare l’abitudine all’idea che da quel posto non me ne sarei andato tanto presto. Resilienza adattiva, così la chiamano quelli bravi: quella sindrome che porta l’uomo a resistere alle situazioni più estreme e coercitive, cercando di forzare la mente a dimenticare l’idea che forse non tornerà mai più a casa. Un po’ come Steve McQueen in Papillon, insomma. Sentirsi ingiustamente confinato a migliaia di chilometri da casa, con la coscienza che probabilmente non la rivedrai più, e tuttavia restare vivo giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, con la sola idea di rivedere casa tua. Il che, nel mio contesto, rende tutto molto più difficile da accettare, visto che — secondo i miei calcoli — mi trovavo tra i monti della Majella, o giù di lì. In ogni caso a solo qualche centinaia di chilometri da casa mia, Roma. Sarebbe forse bastato così poco: una distrazione dei miei carcerieri, una coltre di nubi notturne a oscurare il chiaro di luna, o anche solo un’occasione imprevista da cogliere al volo. Mi sarebbe bastato correre per qualche chilometro nel nero del bosco, fino a raggiungere una strada statale, fermare un’auto, chiedere aiuto.
Sì, sarebbe stato possibile.
Se non fosse che a trattenermi qui non sono uomini.
Sono lupi.
Questo pensiero mi rubava quel poco di sonno che riuscivo a strappare alla notte. E ogni mattina, prima della solita marcia in cerca di cibo, scrutavo silenziosamente ogni movimento, ogni segnale. Aspettavo il momento giusto.
Ma niente. Il branco non lasciava mai nulla al caso. Mi tenevano stretto, confinato al centro della loro formazione: davanti la coppia guida, l’alfa, ai fianchi i più forti – quelli che un tempo avrei chiamato beta – e tutt’intorno, a sigillare il cerchio, i subordinati, le femmine e i cuccioli. Un meccanismo naturale, silenzioso, perfetto.
E io lì, incastrato dentro.
Ma a Carlo Calenda questo sembrava importare poco. Eppure lui, quelle rare volte in cui mi rivolgeva la parola, sembrava essere in quella situazione da molto più tempo di me.
“Mesi…” aveva sussurrato una volta, mentre ci dividevamo i resti di una carcassa di pecora, poco prima che il pastore ci scaricasse addosso una grandinata di pallettoni.
In quell’occasione fu Carlo a salvarmi la vita. Con uno scatto più simile a quello di una bestia che a quello di un uomo, mi afferrò per il polso e ci riparammo dietro il tronco marcio di un vecchio ceppo.
Ricordo nitidamente il primo sparo, il suono sordo del piombo che si conficcava nel legno.
Poi Carlo mi diede una spinta improvvisa, facendomi rotolare giù per un crinale. A sua volta, si lanciò nel fitto dei rovi trascinandomi con lui, correndo a perdifiato.
Ce la vedemmo brutta, io e Carlo.
Ma per lui sembrava tutto ordinaria amministrazione.
Fu allora che quel suo “Mesi…” iniziò a suonarmi in testa in modo diverso — come se volesse dire davvero tanti mesi.
Ma a cosa stava effettivamente pensando quell’un tempo pingue uomo mentre si leccava con serafica cura il suo polso tatuato?
Uno sguardo rapido, intenso, mi infondeva un senso di tranquillità. Come se d’un tratto quei suoi occhi scuri, beffardi ma così profondi avessero aperto in me riserve di dopamina che non sapevo di avere. Forse quella notte sarei riuscito a dormire.
Il tempo è davvero così relativo come dicono, fatto sta che passarono settimane, forse mesi…
Le giornate scorrevano così, come la natura primordiale le ha create: la caccia, la condivisione del cibo, il riposo, il senso del branco. E poi le camminate. Lunghe camminate per boschi, montagne, vegetazione fitta. Di tanto in tanto, nella notte, qualche luce in lontananza. Lì vive l’uomo. La nostra prima minaccia. L’uomo, così violento, sopraffattore, in preda agli estremismi più isterici.
Ogni volta che incrociavamo tracce di umanità, Carlo si fermava: il suo sguardo era attraversato da un fulmine di tristezza. All’inizio pensavo si trattasse di nostalgia, di mancanza di casa… ma col tempo capii che era altro.
E allora perché non condividerlo con me, l’unico altro essere umano del branco? Questo pensiero mi feriva, perché percepivo la sofferenza di quell’uomo. Così integerrimo, e allo stesso tempo così dolcemente complicato. Vivere sul confine, tra un mondo e l’altro, tra bene e male, tra uomo e lupo, e riuscire comunque a restare in equilibrio: una creatura sublime, un prodigio, un dolce fauno dei nostri tempi.
Carlo, se tu potessi anche solo…
Ma non c’era più tempo: dovevamo riprendere la camminata.
Andavamo verso sud e alla mia sinistra vedevo il mare. Probabilmente eravamo in Molise o giù di lì, ma che importava ormai? Sentivo una distanza dal vecchio mondo che sembrava incolmabile. Gli unici confini che riconoscevo erano quelli che la natura mi poneva davanti: un fiume, una montagna, un crepaccio. Il resto non aveva più senso.
Quella notte, però, sarebbe stata diversa. Mi svegliai quasi alle luci dell’alba e subito mi accorsi che Carlo e l’alfa del branco non erano con noi. Mi alzai e li vidi in cima al crinale della collina, illuminati appena dal chiarore della prima aurora. Carlo non si voltò, ma avvertì la mia presenza e fece finta di niente. Poi l’alfa si allontanò, incrociò il mio sguardo e proseguì dritto.
Non capivo cosa stesse succedendo, quando finalmente Carlo si avvicinò a me, mi fissò a lungo e ruppe il silenzio:
«Puoi andare.»
Rimasi senza parole. Riuscii a balbettare solo: «Dove?»
Carlo accennò un sorriso.
«Puoi andare a casa.»
All’inizio sentii uno slancio di gioia — avrei voluto abbracciarlo — ma un istante dopo fui assalito da una malinconia feroce. Carlo Calenda colse la mia condizione. Si avvicinò, poggiò il suo capo sul mio, poi sollevò le labbra a mostrare i denti, come per mettermi alla prova. Rimasi fermo, immobile.
Carlo ringhiò, serrando la mascella, ma io non mossi un muscolo. Poi la sua espressione si rilassò, riprese fiato e accennò un sorriso.
«Sai…» disse. «Ho passato la vita cercando una risposta, un luogo, una…»
«Terra promessa?» lo interruppi.
«È così», rispose piano. «Ma ogni volta che mi illudevo di aver trovato una casa… beh, le cose andavano sempre storte per me.»
Si fermò, si guardò intorno, e dal risvolto della sua camicia — ormai a brandelli — tirò fuori un pacchetto sgualcito di Winston Blu. Ne estrasse l’ultima e l’accese.
«Questa me la tenevo per un momento importante, sai?»
«E questo lo è, Carlo?»
Calenda sorrise e annuì.
«Sai come sono finito qui?» disse, inspirando una lunga boccata di fumo.
Non riuscii a rispondere, tanta era l’emozione.
«Il fatto è che… sì. Il fatto è che tanto tempo fa sono stato buttato in mezzo ai lupi…»
Fece un altro tiro.
«…e ne sono uscito capobranco.»
«Co… come?» balbettai.
«Ho trovato un accordo con l’alfa. Sono capobranco e, in quanto tale, posso darti la libertà.»
«Ma se io volessi rimanere con te?»
«No, devi andare. Il tuo posto non è qui: hai una famiglia, una casa, degli amici.»
«E tu? Non hai una famiglia, una casa… degli amici?»
«Questa è la mia famiglia. Questa è la mia casa. Questi sono gli amici.»
«Allora… io andrei.»
«Vai.»
Feci due passi, poi mi girai verso Carlo. Aveva gli occhi lucidi, tratteneva a stento la commozione.
«Carlo, posso farti una domanda?»
«Una. Una sola domanda.»
«Ma di preciso… chi ti ha gettato in mezzo ai lupi?»
Carlo spense la sigaretta e mangiò il mozzicone.
«Come chi? Loro, amico mio. Loro…»
«Ma chi sono “loro”, Carlo?»
«Una domanda. Una sola domanda.»
Carlo Calenda si voltò e con un balzo si infilò in un cespuglio di rovi, scomparendo.
A distanza di quasi due anni da quei giorni incredibili, ogni mese, quando la luna completa il suo ciclo riempiendo il cielo della sua circonferenza luminosa, mi fermo a osservarla… e non riesco a trattenermi dall’ululare, sapendo che da qualche parte, tra montagne e boschi, Carlo Calenda sta cantando, osservando la stessa luna.