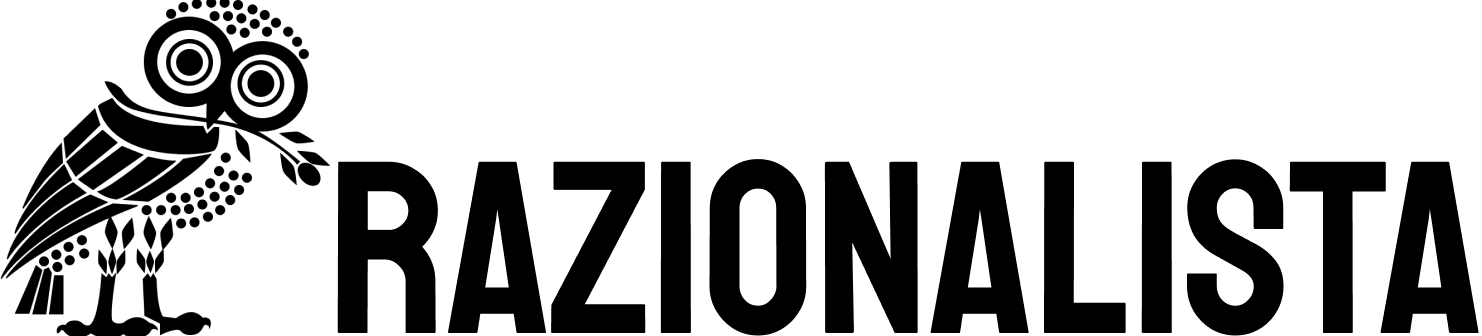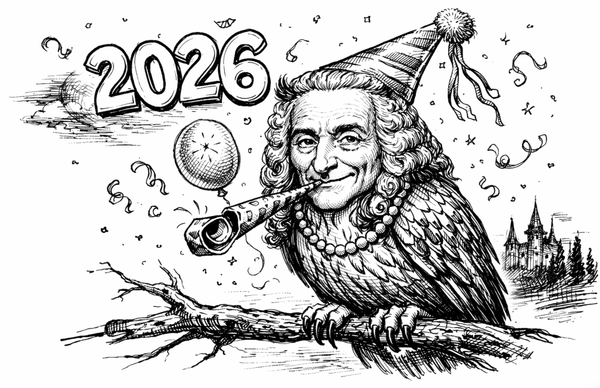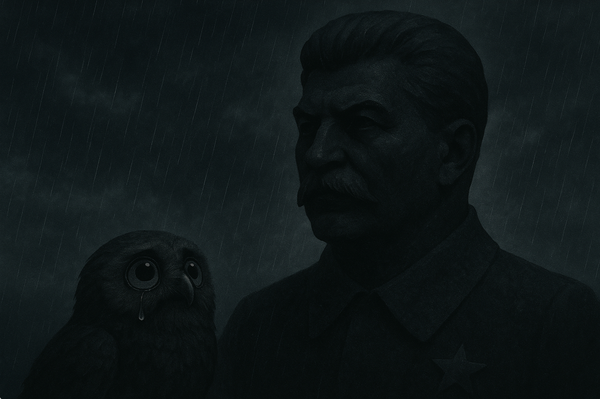La soglia di sbarramento è una cagata pazzesca?

Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia della vittoria di Eugenio Giani, candidato del cosiddetto “Campo largo” in Toscana. Una vittoria piuttosto netta, complimenti a lui.
Ma la notizia che più salta agli occhi è un’altra: la candidata presidente di Regione, Antonella Bundu, a capo della lista “Toscana Rossa” (che riunisce Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e altre formazioni di quella che un tempo si definiva sinistra extraparlamentare, oggi potremmo dire sinistra extraPD), ha ottenuto il 5,1%. Tuttavia, avendo il suo nome raccolto più preferenze della lista e risultando quest’ultima di poco sotto la soglia del 5%, la Bundu resterà esclusa dal Consiglio regionale.
Lei ha già annunciato che presenterà ricorso, ma al di là dell’esito e del singolo caso, una domanda sorge spontanea: questa soglia di sbarramento, ormai accettata quasi come un dogma nel gioco delle nostre leggi elettorali, non sarà mica una cagata pazzesca?
Facciamo un breve excursus.
Fino alla legge elettorale del 1993 — il celebre “Mattarellum”, così chiamato in onore del suo ideatore e attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella — in Italia vigeva un sistema proporzionale puro. In parole povere: i seggi venivano assegnati in proporzione matematica ai voti raccolti da ciascun partito.
È noto come la Prima Repubblica sia stata caratterizzata da un susseguirsi di cadute di governo, rimpasti e una sostanziale instabilità politica. Perché? Perché la Democrazia Cristiana, storico primo partito italiano dal dopoguerra fino ai primi anni ’90, non raggiunse mai una percentuale di voti sufficiente per governare da sola. Questo portò alla formazione di alleanze parlamentari spesso fragili. Senza contare che la DC, al suo interno, era attraversata da correnti in conflitto tra loro, rendendola incapace di garantire una reale stabilità di governo nel lungo periodo. Una bella gatta da pelare.
Come dicevamo dal 1993, quindi, si sono susseguite una serie di leggi elettorali mirate alla sostanziale governabilità del paese e coesione delle camere.
Brevemente:
1. Mattarellum (1993–2005)
Legge n. 276 del 1993
Sistema misto: 75% dei seggi assegnati con collegi uninominali maggioritari, 25% con proporzionale. Introdusse la logica del “bipolarismo” (centrosinistra vs centrodestra).
2. Porcellum (2005–2015)
Legge n. 270 del 2005, ideata da Roberto Calderoli
Sistema proporzionale con premio di maggioranza. Le liste erano bloccate, senza preferenze. Il premio di maggioranza garantiva la maggioranza assoluta dei seggi alla coalizione vincente, anche con pochi voti di scarto.
Dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2014.
3. Italicum (2015–2017)
Legge n. 52 del 2015, promossa da Matteo Renzi
Valido solo per la Camera dei deputati.
Sistema proporzionale con premio di maggioranza alla lista che superava il 40% o che vinceva al ballottaggio. Introduceva capilista bloccati e preferenze per i candidati non capilista.
Non entrò mai pienamente in vigore perché nel frattempo cambiò la legge per il Senato e intervenne di nuovo la Consulta.
4. Rosatellum (2017–oggi)
Legge n. 165 del 2017, proposta da Ettore Rosato
Sistema misto: circa un terzo maggioritario uninominale e due terzi proporzionale con liste bloccate.
Non prevede premio di maggioranza, ma incentiva le coalizioni pre-elettorali. È la legge attualmente in vigore (utilizzata nel 2018 e nel 2022).
Una riflessione
La mia generazione è cresciuta con l’idea, quasi implicita, che l’Italia fosse un Paese ormai stabilmente bipolare. Un’idea figlia di un contesto storico ben preciso: dal 1994 in poi abbiamo vissuto nell’orbita di Silvio Berlusconi, candidato premier naturale, a capo di una coalizione (più o meno solida) e di governi tra i più longevi della Repubblica.
Di conseguenza, sono nate coalizioni “anti-berlusconiane” altrettanto nette, e ci siamo sentiti — volenti o nolenti — appartenenti a una “parte” precisa. Un sistema che, paradossalmente, ci ha fatto percepire l’Italia più simile al bipartitismo americano che al parlamentarismo italiano. Ma a ben vedere, quella era un’anomalia storica, non la regola.
Tutte le leggi elettorali elencate, da allora in poi, hanno condiviso un tratto comune: la soglia di sbarramento (tra il 3 e il 4%) per accedere alla rappresentanza parlamentare. La logica è nota: evitare la frammentazione e rendere il Paese più governabile.
A prima vista può sembrare un principio sensato, ma basta rifletterci un attimo per accorgersi che qualcosa non torna.
Intanto, è curioso attribuire il problema della governabilità ai cosiddetti “partitini”, forze che — anche nei casi migliori — portano in Parlamento da uno a tre seggi. È difficile immaginare che da soli possano far cadere un governo.
In secondo luogo, è una visione antistorica: negli ultimi trent’anni, i governi non sono mai caduti per colpa dei piccoli partiti esterni alle coalizioni, ma quasi sempre per fratture interne alle maggioranze o addirittura dentro gli stessi partiti di governo.
Basti pensare al caso del Movimento 5 Stelle, che nella legislatura conclusa nel 2022 si è praticamente dimezzato:
- alla Camera, da circa 222 deputati a poco più di 100;
- al Senato, da 112 a circa 50.
Alla fine, il Gruppo Misto risultò il più numeroso del Parlamento, composto in gran parte da ex 5 Stelle.
E non è un episodio isolato. Nel 2013 nacque il Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, una scissione da Forza Italia fatta per garantire la fiducia al governo Letta. Ancora prima, nel 2010, Berlusconi riuscì a strappare una fiducia in extremis grazie a una serie di compravendite parlamentari, con il celebre caso Scilipoti, che compensò la fuoriuscita di Fini e dei suoi da Alleanza Nazionale — i quali, nel frattempo, avevano formato Futuro e Libertà continuando però a occupare i seggi fino alle elezioni successive.
A tutto ciò si aggiunge la costante creazione, legislatura dopo legislatura, di nuovi gruppi parlamentari nati da scissioni e confluenze, molti dei quali si sono poi dissolti senza lasciare traccia.
In sintesi, questa “inquisizione” verso i partitini non ha mai prodotto l’effetto sperato. Anzi: mentre la soglia di sbarramento tagliava fuori forze politiche minori con un consenso reale, dentro il Parlamento continuavano a moltiplicarsi gruppi e sottogruppi creati da eletti di partiti maggiori.
Basta guardare la composizione del Parlamento alla fine del governo Draghi nel 2022 per rendersi conto che, di “governabilità”, ne abbiamo guadagnata ben poca.
Però la convinzione rimane: un partito al di sotto di una certa soglia NON deve avere rappresentanza.
In numeri: se dovessero votare 30 milioni di persone, un partito che prende il 2,5 percento, avrebbe una base di circa 600.000 – 750.000 elettori. Oggettivamente un numero considerevole.
Prendiamo ad esempio la Camera. Avendo ormai, dopo la miserabile e sciagurata legge costituzionale del 2020, proposta dal M5S, che ha portato la Camera dei Deputati da 630 a 400 membri, con un 2,5 percento corrisponderebbero, calcolando con un proporzionale secco, circa 10 seggi.
Ok, forse così, a botte di “partitini” si creerebbe una situazione potenzialmente instabile. Ma il proporzionale secco è ormai relegato al passato. Possibile che non si possa creare una circostanza tale per cui, in un’ottica certo di governabilità, ma anche di democrazia rappresentativa reale, un “partitino” non possa portare un numero giusto di rappresentanti?
Eleggere anche solo 1 deputato, sembra paradossale, ma è fondamentale nell’assetto democratico e parlamentare.
Infatti un deputato può:
- Proporre leggi: può presentare progetti di legge propri o firmare quelli di altri parlamentari.
- Partecipare alle commissioni parlamentari, dove si esaminano proposte di legge e si discutono emendamenti.
- Votare in aula: ogni parlamentare partecipa alle votazioni su leggi, mozioni, fiducia o sfiducia al governo.
- Interrogazioni e interpellanze: può rivolgere domande ai ministri e ottenere chiarimenti sull’attività del governo.
- Partecipare a commissioni di inchiesta: indagare su fatti pubblici o vicende di interesse nazionale.
E aggiungo un elemento fondamentale. Ci stiamo lamentando, a ragion veduta, del graduale impoverimento della classe politica italiana. Questa constatazione va di pari passo con la convinzione che serva sempre di più polarizzare l’assetto partitico.
Fino ad ora ci è riuscita solo la destra.
A sinistra (o centri-sinistri, o popolar-radical-riformisti-sinistri, o grandi sinistri)? Che vogliono fare? Mi chiedo: non è che, magari, dare spazio a formazioni non allineate, di qualunque tendenza nello scacchiere progressista, potrebbe essere una cosa intelligente, visto la sostanziale latitanza di idee?
E sappiamo bene che una soglia ipotetica del 4% finirebbe per tagliare le gambe a una lista appena nata o non allineata: carenza di risorse finanziarie, scarsa visibilità mediatica e, come se non bastasse, quell’insopportabile ritornello del “voto utile” che, fino a oggi, non posso fare a meno di chiedermi: utile a chi? E utile a cosa?
Risultato: per raggiungere l’agognato 4 percento (e molto raramente accade), si creano carrozzoni di simboli residuali, spesso guidati da una faccia più o meno nota, che dopo le elezioni cessano di esistere. Questi gruppi replicano le stesse dinamiche dei partiti più grandi, ma in scala ridotta: con una struttura minima e qualche fondo residuale, diventano di fatto capo-cartelli di progetti confusi, finalizzati solo a non sfigurare alle elezioni, seguendo in sostanza le stesse strategie fallimentari dei “cugini” più votati.
A sinistra ne potrei contare, ahimè, a dozzine.
In modesta definitiva:
Non sarebbe bello, democratico, lineare e, per Dio, giusto, che la democrazia rappresentativa sia effettivamente rappresentativa (con ovviamente un occhio alla amata governabilità)? Se si vuole davvero dare una possibilità alle cosiddette “nuove facce” — termine che trovo molto brutto, a mio parere — non ci si rende conto che una legge che taglia fuori realtà nascenti o “minoritarie” è una legge che, di fatto, sposta l’assetto del concetto di democrazia rappresentativa del nostro Paese?
In altre parole, questa soglia di sbarramento al 3 - 4% non la si può definire come profondamente anti-democratica?
Se guardiamo al passato, prossimo e remoto, ci rendiamo conto che i personaggi che oggi amiamo citare in frasi a effetto, che hanno proposto un’alternativa reale, sociale e civile, e che hanno creato paradigmi inizialmente utopici, poi diventati cultura comune e legge… oggi sarebbero sotto la soglia di sbarramento.
Quindi con serena e liberale convinzione mi sento di dire che sì, la soglia di sbarramento potrebbe essere una cagata pazzesca.